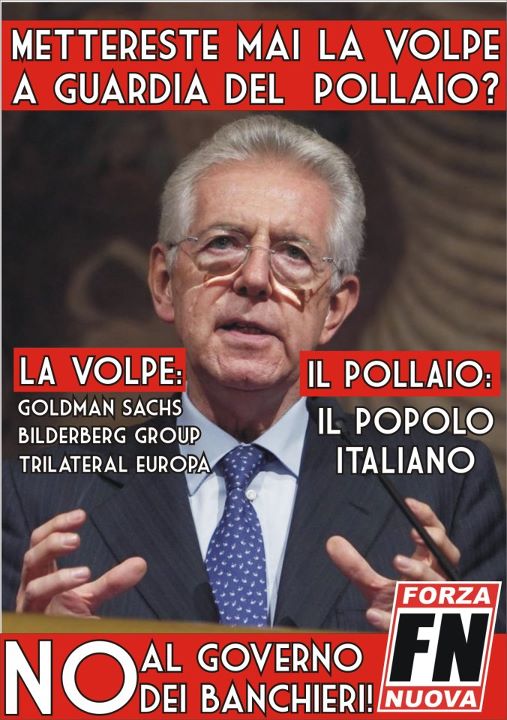4 su 5
Ci sono diversi modi per tentare di risanare i conti di uno Stato che è in rosso, e questa la sarà scelta che Monti si troverà ad affrontare. Ci sono misure su cui tutti sono d’accordo, come la lotta all’evasione fiscale o il taglio dei costi della politica (e quindi non ne parlo qui, non vedo possibili obiezioni), e altre che invece scontentano una parte o l’altra: chi vuole un risanamento di marca più socialista pensa principalmente a una tassa patrimoniale e alla reintroduzione dell’ICI, chi lo vuole di marca più liberale pensa principalmente alla revisione dell’articolo 18 e all’aumento dell’età pensionabile. Io dico: scontentiamo tutti.
EQUITÀ E MERITOCRAZIA
Facciamole tutte, queste misure, perché il risanamento di cui ha bisogno l’Italia è sostanzioso. Alcune sono già nella legge di stabilità approvata da Berlusconi prima di dimettersi, l’auspicio è che vengano rafforzate. Ma anche – e più importante – perché questo Paese manca di due cose: equità e meritocrazia. E, al contrario di quello che pensano molti in Italia, sono due cose inestricabilmente interconnesse.
Equità vuol dire che tutti abbiano le stesse possibilità di partenza, che anche l’operaio possa volere il figlio dottore. Ma vuol dire anche che ciascuno abbia il miglior servizio possibile dalla società in cui vive. Meritocrazia vuol dire che il criterio con cui si scelga chi far operare sia quello del merito, e nessun altro. Che quindi siano limitati il più possibile tutti gli altri fattori, in particolare quello del censo. Ma questo principio – non ci scordiamo – non è un principio astratto o suprematista: noi non vogliamo premiare i più bravi perché sono più bravi, noi li vogliamo premiare perché fanno il miglior servizio possibile alla società. Un architetto migliore fa i ponti migliori, un dottore migliore cura meglio la gente, un pizzaiolo migliore fa la pizza più buona. Incentivare i migliori conviene a tutti.
ICI
Non c’è nulla da fare, in un Paese stagnante e in cui nessuno investe, la differenza la fa il mercato immobiliare. Gli affitti costituiscono spesso il 30 o anche il 40% di uno stipendio: questo vuol dire che chi ha una casa di proprietà, quasi sempre ereditata, ha uno stipendio notevolmente più alto. E questo vale ancora di più fra i giovani: se mamma e papà hanno una casa da darti, o ti pagano l’affitto, puoi permetterti di andare in un’altra città a studiare. Altrimenti devi lavorare prima e poi fare l’università, oppure assieme, ma con meno efficienza per entrambe. Finiti gli studî vale la stessa cosa, ed è il motivo per cui questo esercito di fantomatici “bamboccioni” non si muove da casa dei genitori. Chi si può permettere un affitto con gli stipendî da fame che hanno i ventenni in questo Paese? Pochissimi: la differenza fra chi può e chi non può la fa soltanto l’avere genitori (o i nonni) che ti lasciano la casa. Questo non ha nulla di meritocratico.
PATRIMONIALE
Il principio è lo stesso. A noi sta bene che ci siano persone che guadagnano di più, se questo servizio è importante per la società – ad esempio, dovremmo pagare molto di più gli insegnanti, che vorrebbe anche dire averne di migliori, ci sarebbe più concorrenza per il posto, più specializzazione –, il problema non è quanto uno guadagna, che qualcuno guadagni tanto è parte di un sistema virtuoso. Però ci sono persone che la propria ricchezza l’hanno ereditata e non se la sono guadagnata facendo un servizio alla società. Un po’ siamo tutti così, perché da bambini sono i nostri genitori a crescerci e comprarci i vestiti, ma sarebbe bene limitare questo principio il più possibile. Rispetto a ciò è ovvio che fare una tassa sul patrimonio colpisce di più i patrimonî accumulati rispetto a un innalzamento delle tasse (sullo stipendio). Il primo sono le entrate passate, il secondo quelle correnti. Se c’è un’emergenza, ha più senso ricorrere alla prima.
ARTICOLO 18
Nel 2002 ero alla famosa manifestazione di Cofferati: sbagliavo. In Italia c’è un sistema a due velocità, e sono due velocità enormemente differenti: la prima è una Ferrari, la seconda è un triciclo. Le persone con un contratto a tempo indeterminato, sono la larghissima maggioranza degli over 40, sono la classe più tutelata del mondo. E poi ci sono quelli che sono arrivati dopo, gli under 40, che sono la classe meno tutelata nel mondo occidentale. Che queste due condizioni possano coesistere, nella stessa economia, è il più grande sintomo del male dell’Italia: la difesa corporativa. Ciascuno difende sé stesso e i proprî privilegi, e quando bisogna chiedere sacrifici, li si impongono a chi non si può difendere, a quelli che verranno. Siccome l’economia italiana non poteva più reggere con le chiusure che la caratterizzavano, si è deciso di flessibilizzare, però ognuno ha difeso il proprio – i sindacati hanno difeso i loro iscritti – e alla fine è stato colpito soltanto chi già da prima aveva poco: a forza di co.co.co e nessun ammortizzatore sociale, in quella che è davvero la precarietà. Eppure il principio dovrebbe essere semplice: ho bisogno di una baby sitter? Assumo una baby sitter, perché ho quel bisogno. E se quel bisogno non c’è più? Devo mantenere a pagarla anche se non mi serve più? Questo concetto è chiaro sotto ai 15 dipendenti, non si capisce perché non debba valere al di sopra. Un’economia in cui nessuno è avvantaggiato è un’economia che si può permettere dei sussidî per questo standard a tutti, se invece è solo una classe ad avere delle tutele (che costano alla società), quel costo sarà pagato interamente a spese dell’altra (senza offrire nessuna garanzia). Vogliamo che siano, ancora una volta, quelli che non hanno a pagare le tutele di quelli che hanno?
ETÀ PENSIONABILE
Anche qui vale lo stesso discorso: ci sono quelli che hanno la pensione a 65 anni e quelli che non si sa quando ci andranno (se continua così, 120). Perché, è ovvio, il costo sociale di andare in pensione prima è a carico di tutti gli altri, i soldi non si inventano. Se abbassassimo l’età pensionabile a 30 anni, il costo di quelle pensioni dovrebbe essere pagato – col proprio lavoro – dai lavoratori che hanno fino ai 30 anni. Perciò si tratta di decidere: ripartire equamente quel sacrificio necessario o farlo soltanto a carico di quelli che verranno? E, se ci si pensa, qualunque procrastinazione del tipo “età pensionabile a 67 anni nel 2050 (ma anche 2027)” è qualcosa di eticamente scandaloso: vuol dire che c’è bisogno di un sacrificio, ma questo sacrificio lo si chiede solo ad alcuni, e il pagamento di questo privilegio fino alla data in questione, cioè il costo di quei due anni di meno fino al 2027, la pagano gli esclusi. C’è chi obietta che questo vorrebbe dire venire meno al patto sociale, perché quelle persone hanno cominciato a lavorare con delle prospettive precise offertegli dalla generazione precedente (a cui loro hanno pagato la pensione). Bene: ma se quella promessa era fasulla mica se la possono rifare con quelli dopo, mica si può ripetere – e anzi aggravare – lo stesso inganno. Quel patto non è stato fatto con chi ora ha 5 anni, è stato fatto con chi ora ne ha 85: e però a pagare la pensione sarà il primo. Come si fa a chiamare questo equità?
 È successa la cosa peggiore che possa succedere in un Paese civile. Il linciaggio. Un campo rom dato alle fiamme. La vendetta collettiva e biologica – per nascita. I migliori di noi s’indignano, che altro si può fare? I peggiori, invece, pensano – quante volte l’ho sentito dire – che però anche loro delle volte se la cercano. Tutto lì. Ma ipotizziamo il caso inverso.
È successa la cosa peggiore che possa succedere in un Paese civile. Il linciaggio. Un campo rom dato alle fiamme. La vendetta collettiva e biologica – per nascita. I migliori di noi s’indignano, che altro si può fare? I peggiori, invece, pensano – quante volte l’ho sentito dire – che però anche loro delle volte se la cercano. Tutto lì. Ma ipotizziamo il caso inverso.

 Capirete bene, quindi, che per un tifoso della Fiorentina che ha passato infanzia e adolescenza a Roma, Fiorentina-Roma è la partita dell’anno (infatti mi ero presentato in
Capirete bene, quindi, che per un tifoso della Fiorentina che ha passato infanzia e adolescenza a Roma, Fiorentina-Roma è la partita dell’anno (infatti mi ero presentato in