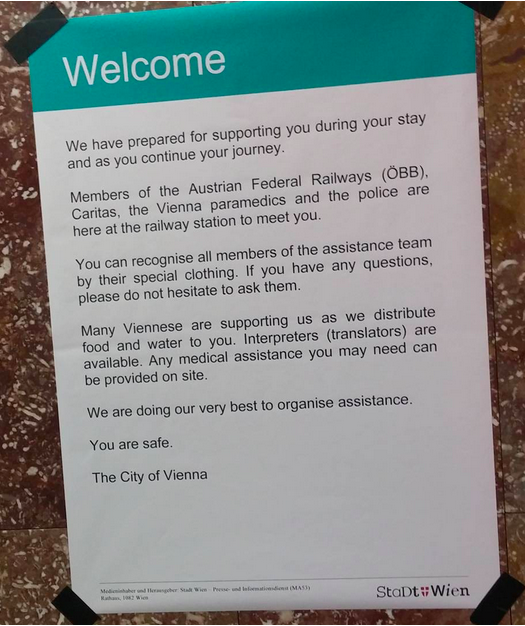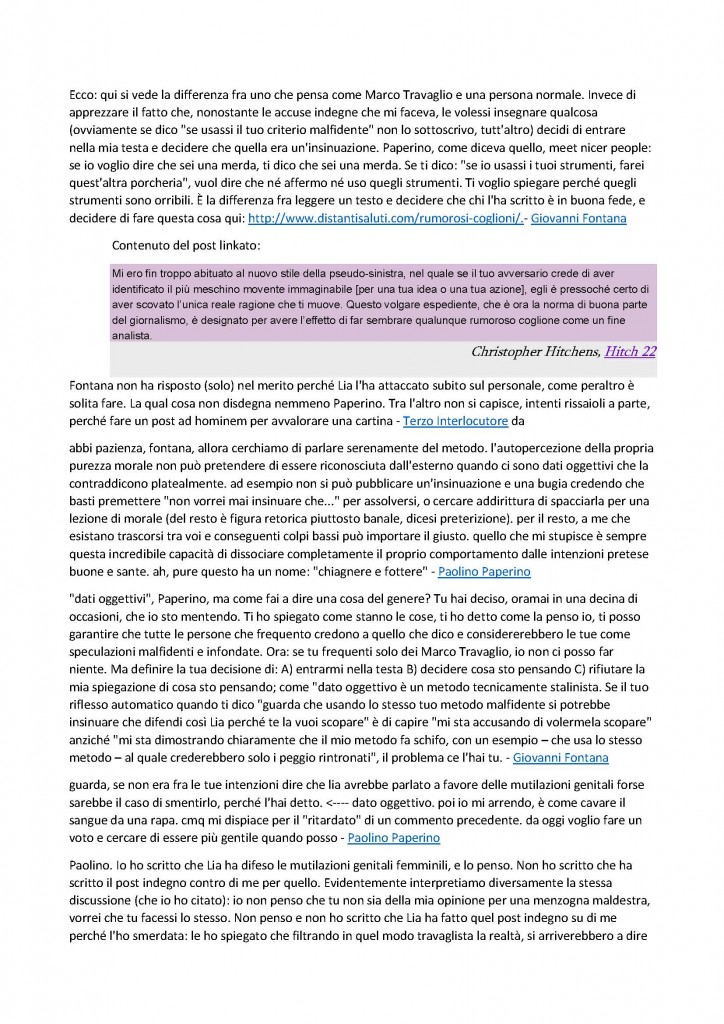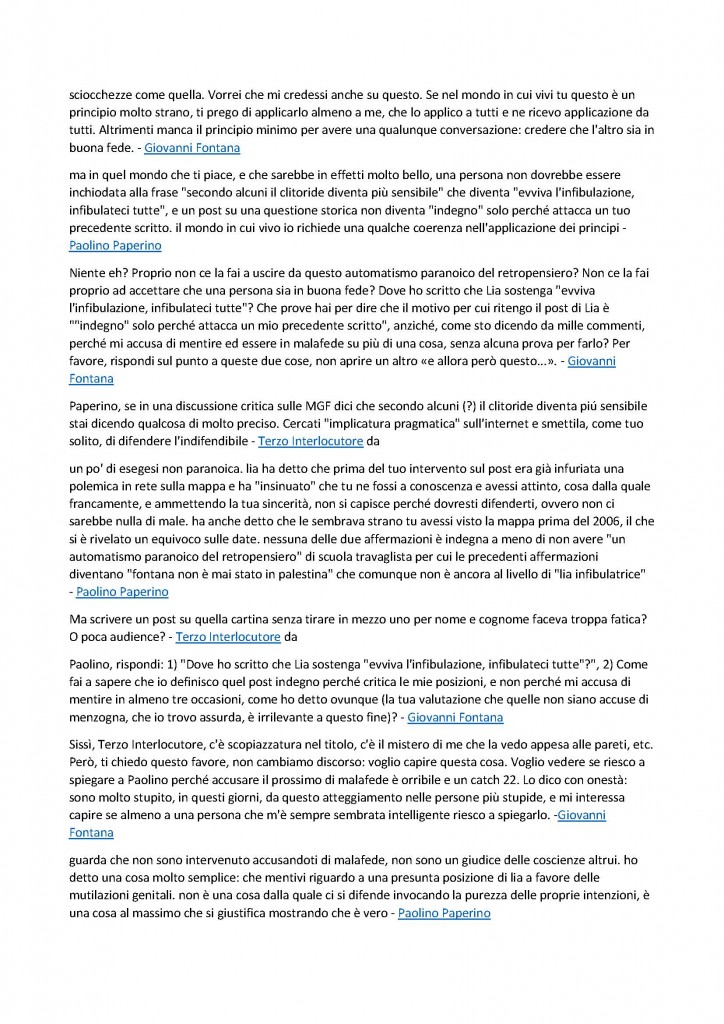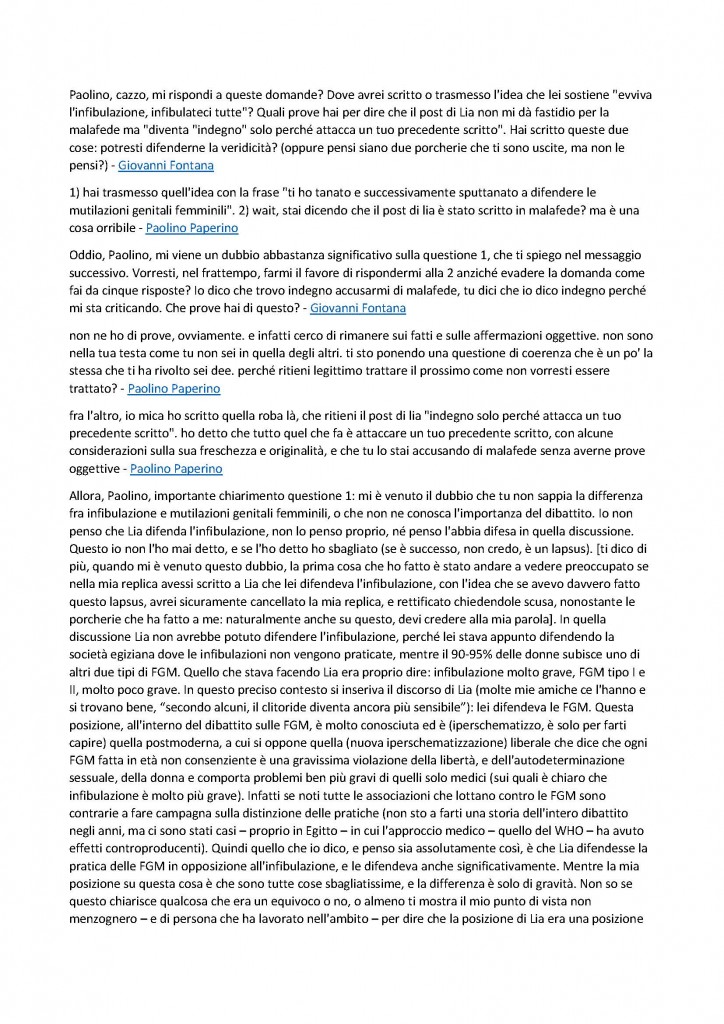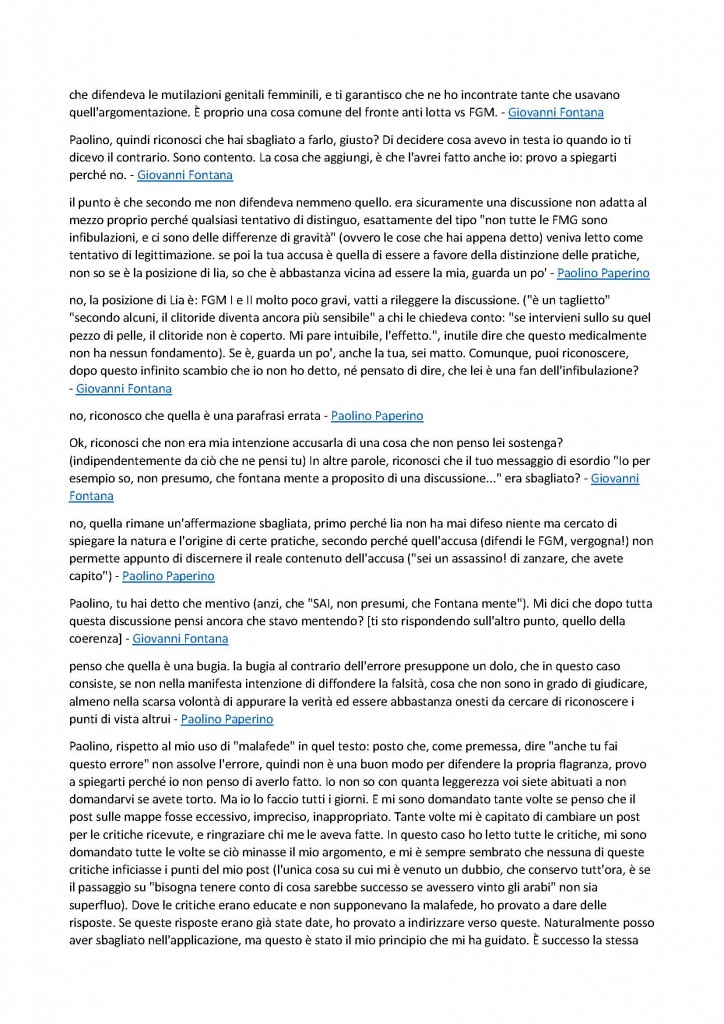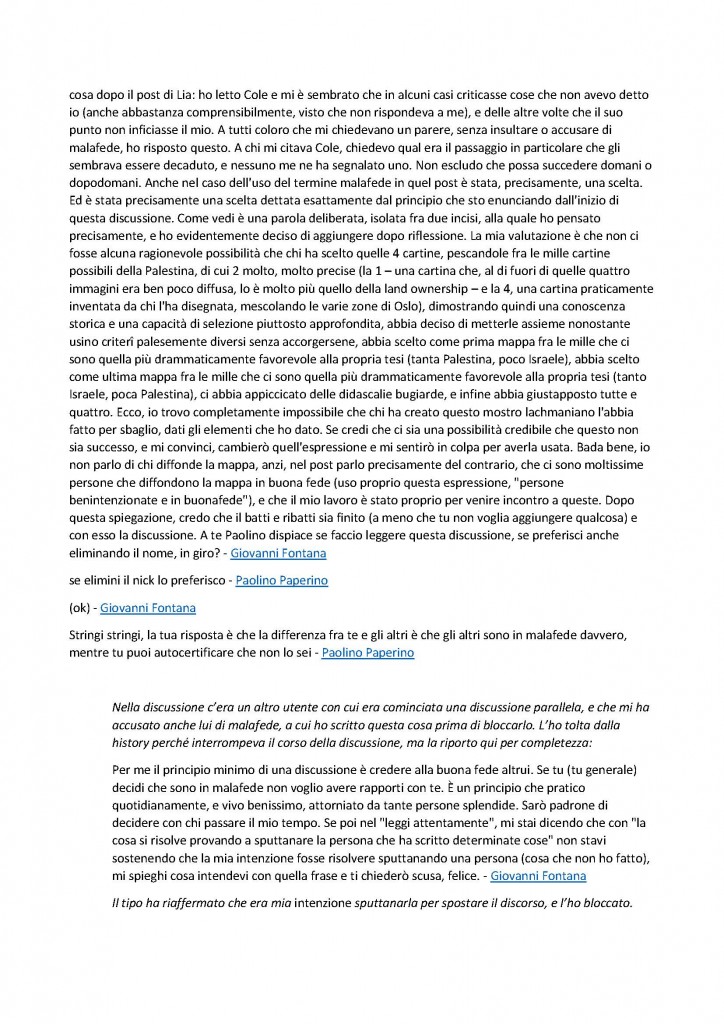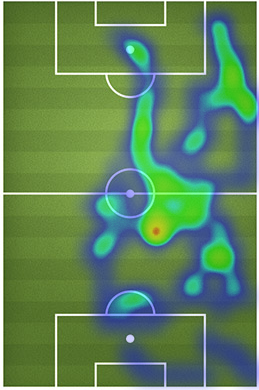5 su 5
Lunghissima e tediosissima premessa
Questo è probabilmente il post di questo blog fruibile da meno lettori. Se cominciate a leggerlo ci sono molte possibilità che finiate a dire: ma che cosa sto leggendo? Si parla di etica, di amicizia, di famiglia. Se ne parla, però, in un modo in cui probabilmente non avete mai parlato dell’amicizia, delle persone alle quali si vogliono bene. Oppure in un modo che pensate eccessivo: eccessivamente emotivo, eccessivamente razionale, eccessivamente fiducioso. È una cosa che ho scritto per me, per metterla assieme per iscritto e rileggerla, e avrei preferito farla leggere a poche persone; poi mi sono sentito un egoista e un vigliacco ad avere questo pensiero (ho molta paura di rimanere deluso) e perciò mi sono imposto di pubblicarla qui.
Inoltre questo post parte da alcune premesse, ovviamente opinabili, senza le quali il post perde completamente di senso ed è quindi inutile leggerlo. Le premesse sono di due ordini, di metodo e di contenuto. Quelle di metodo (che possiamo definire utilitariste e illuministe) sono:
- I) Il nostro obiettivo (quello dell’etica) è garantire il maggior benessere delle persone, o diminuirne le sofferenze.
- II) L’unico strumento efficace di conoscenza del mondo che abbiamo è la ragione: dove per ragione intendo il metodo scientifico, lo scetticismo, il rigore. Non che la razionalità sia un metodo al 100% efficace, tutt’altro, è che è l’unico che ha una qualche efficacia.
- III) Per questo qualunque proposizione, argomento o obiezione deve essere vagliato secondo le regole elementari della logica: fallacie logiche come “se sostieni la cosa x, che porta a y, allora finirai a sostenere z” (piano inclinato), “dato che non possiamo sapere x, allora y è vero” (argumentum ad ignorantiam), “x è sbagliato perché è x”(petitio principii), o qualunque tipo di non sequitur, non sono ammesse. Per contestare un argomento bisogna contestarne le premesse o il ragionamento.
- IV) Condividere una decisione con più persone ha statisticamente più possibilità di produrre una soluzione migliore rispetto a produrla da soli. Ciò non vuol dire che tutte le volte sia vero, ma che sono più le volte in cui avere altri pareri migliora l’accuratezza di una decisione, rispetto alle volte in cui la danneggia.
Quelle di contenuto:
- A) Essere veramente amici di una persona vuol dire tenere alla sua felicità o infelicità quanto alla propria. In pratica, alla domanda: «meglio che io venga torturato per un giorno, o l’amico venga torturato per due giorni», la risposta è necessariamente la prima (a parità di tipo di tortura, capacità di sopportare il dolore, etc.).
- B) È possibile fidarsi delle persone. È possibile fidarsi al punto da fidarsene quanto ci si fida di sé stessi. Una fiducia che investe anche il futuro: mi fido che quella persona non diventerà cattiva.
- C) Non aspiriamo a un sistema perfetto. Aspiriamo a un sistema migliore di quello che usiamo ora. Non aspiriamo a un sistema senza errori, ma a un sistema che porta a meno errori di quello che usiamo ora.
Ultima cosa: questo post continuerà a essere editato, per cercare di renderlo più accurato, più preciso, più esauriente. Se qualcuno fa delle obiezioni che fanno cadere un mio punto, quel punto sarà rimosso, e così via.
LA CONDIVISIONE
Alcuni ricorderanno il post che avevo scritto a proposito della famiglia: dicevo che trovavo vacillante il concetto dell’affetto scontato, basato sull’accidente e non sul merito. Dicevo che è insensato dare completa fiducia e affetto indipendentemente dalla stima e dai comportamenti. Non contestavo l’esistenza di una istituzione, la famiglia, in cui si cerca di fare il bene di tutti, e non si privilegia il proprio a scapito di quello degli altri. Ora mi trovo a domandarmi: ma perché questo concetto non dovrebbe applicarsi anche agli amici? È naturale che si voglia che la persona della propria vita (marito/moglie/coniuge/compagno) sia la persona con la quale più si vuole condividere, ma perché non bisognerebbe condividere anche con le persone alle quali più si vuole bene?
Per amici, intendo veri amici, una stretta minoranza di persone, ognuno ne ha un diverso numero (qualcuno non ne ha alcuna). Sto quindi parlando di persone elette, che abbiamo scelto al nostro fianco per le loro qualità. Questo porta all’esclusione immediata di qualunque persona che si ritiene una (o più) di queste tre cose:
- 1) Disonesta. Cioè una persona di cui non ci si fida al 100%, che ci potrebbe mentire o ingannare per trarne vantaggio.
- 2) Stupida. Cioè incapace di sviluppare un ragionamento E (importante) incapace di rendersi conto di questi limiti.
- 3) Cattiva. Cioè desiderosa di privilegiare il proprio bene su quello degli altri coinvolti, quindi non disposta a sacrificarsi.
*Aggiunta del 06/10: Il punto 2) (la stupidità), messa assieme alla premessa di metodo IV (condividere decisioni, fa prendere decisioni migliori) necessitano di maggiore chiarezza. Prendere decisioni assieme è meglio perché, assumendo l’intelligenza di tutti, ciascuno saprà riconoscere la propria ignoranza (in principio, o mostratagli durante la discussione). Se io non capisco nulla di meccanica, delego la decisione a chi ne sa. Allo stesso modo, non è necessario essere tutti intelligenti allo stesso modo, l’importante è che una persona sappia riconoscere i proprî limiti quando le vengono mostrati.*
*modificato il 06/10: Per condivisione intendo una cosa molto radicale: che il processo decisionale di qualunque scelta individuale sia potenzialmente (potenzialmente, è importante) condiviso con tutte queste persone; e che i costi e i benefici di queste scelte siano condivisi da tutte. In altre parole: le decisioni si prendono collettivamente e le risorse coinvolte in queste decisioni (tempo, denaro, fatica, vantaggi, svantaggi) sono quelle di tutti a prescindere da chi sia il più diretto interessato da queste decisione. Il punto è proprio questo: ciascuno è ugualmente interessato dalle cose che capitano a tutti gli altri. In pratica quello che si fa, normalmente, in una famiglia. Ciò vuol dire che se una (o più) persone deve prendere una decisione importante, tutte le persone vengono coinvolte e hanno voce in capitolo, e tutte le persone condividono i costi e i benefici della decisione adottata.
Importante: la condivisione è un metodo di decisione e distribuzione delle risorse. Non è una ricetta con un contenuto su cosa è meglio fare in determinate situazioni: è una valutazione su quale è il miglior processo decisionale di quelle situazioni, e sul fatto che le risorse di tutti sono messe in comune. In questo metodo si cerca la migliore spartizione di tempo, delle risorse, e delle competenze delle persone coinvolte. Ciò vuol dire che su alcuni temi la migliore spartizione potrebbe essere benissimo “ciascuno per sé”, come facciamo oggi: non è che ogni volta che compro uno yogurt devo telefonare alla mia famiglia per accertarmi dell’acquisto, se è la marca più buona, se la spesa vale la pena, se è meglio che lo faccia qualcun altro, etc. In quei casi, semplicemente, si considera che il tempo impiegato a discutere/condividere una cosa simile non vale il risparmio di qualità/tempo/denaro.*
Nei fatti, il sistema che adottiamo ora è un sottoinsieme della condivisione: è una specifica forma di ripartizione in cui abbiamo deciso, in maniera del tutto casuale (e solo per convenzione, perché siamo stati educati così), che il modo migliore per garantire la felicità a tutti e su tutti i temi è “ciascuno per sé” per i single, e “condivisione solo con moglie/marito/(figli)” per chi ha una famiglia. Ma che questa ripartizione, scelta in maniera completamente casuale, sia la migliore in assoluto sarebbe un caso enorme: del resto, anche il solo fatto di disporre quando si ha più necessità, e mettere a disposizione quando se ne ha meno, tempo o denaro da/per altre persone dà un inevitabile vantaggio (in una settimana molto piena è utile che un’altra persona mi sgravi di una faccenda, anche molto personale, perché quel tempo, in quel periodo, “vale” di più per me). Il metodo “ciascuno per sé” è un metodo prudente, ma se ci si fida delle tre premesse di cui sopra, è sicuramente più inefficace.
Questo metodo ha a che fare con le scelte interne (come organizziamo la nostra vita? A chi, fra noi, spetta questo compito? Facciamo un viaggio?), ma anche e soprattutto con le scelte etiche da fare verso l’esterno: fare la raccolta differenziata? Accettare un lavoro in una società di scommesse? Trasferirsi in un altro continente per lavoro? Se si ha a che fare con persone oneste, intelligenti e buone non c’è ragione per la quale ciascuna decisione della nostra vita non dovrebbe essere condivisa.
ESEMPÎ
Si rompono le tubature in casa di Carla: questo non è un problema suo, ma è un problema di tutti. Non sarà lei a dover chiamare l’idraulico e occuparsene: o magari sì, perché è più facile organizzativamente. Ma è altrettanto possibile che se ne occupi Barbara, perché ha più tempo in quel periodo, o Daniele, perché la mattina in cui verrà l’idraulico passa vicino a casa di Carla. Magari il guadagno in termini di tempo è poco, ma non c’è ragione per la quale dovrebbe “spettare” al proprietario delle tubature.
Antonio deve decidere se accettare un’offerta di lavoro all’estero. Anziché parlarne con la moglie e scambiare un parere con qualche amico, ma sempre con il dato assunto che quella è una decisione da prendere esclusivamente per il proprio bene, perché la decisione di Antonio non viene condivisa? Se Antonio partirà per l’Australia questo avrà conseguenze sul benessere di tutti, non solo la moglie, ma anche tutti coloro che popolano la sua vita. Magari la madre di Andrea è ammalata e c’è bisogno che qualcuno la accudisca, perché questo è responsabilità esclusiva di Andrea? Perché non dovrebbe farsene carico anche Antonio?
Silvia non ha un buon titolo di studio, e il massimo a cui può aspirare è fare un lavoro che non le piace; Matteo guadagna ben più di ciò che gli serve a sostentarsi. Se fossero una coppia, la cosa si risolverebbe con una spartizione dei compiti. Ma che senso ha che questo avvenga solo se c’è quel rapporto di coppia? Perché non dovrebbe avvenire esattamente lo stesso, magari Silvia può aiutare Matteo quando gli si rompe la macchina, gli innaffia i fiori, magari dove può lo aiuta nel fare il suo lavoro, o a gestire le mille incombenze che ognuno di noi ha nella propria vita.
Maria e Carlo devono decidere a quale scuola elementare mandare il proprio figlio Giuseppe. Perché non dovrebbero partecipare, proprio alla decisione, tutte le persone veramente loro amiche? Visto che tutti hanno interesse a fare il bene di Giuseppe, la decisione dovrebbe essere presa assieme. Anzi: anche la decisione di fare un figlio dovrebbe essere condivisa, proprio perché il benessere di questa persona, e quella di tutte le persone che tengono alla coppia, sarà stravolto (in senso positivo o negativo) dalla nascita di un bambino.
Per ragioni etiche, Francesca prende la risoluzione di non comprare più prodotti di una determinata marca (o di non frequentare più una persona che si comporta male con il prossimo). Se Francesca non è colta da un raptus ma prende la sua decisione per motivi razionali, perché questi motivi non dovrebbero essere condivisi anche dalle altre persone che le sono amiche? Quindi, dopo una discussione, non è sua la decisione di smettere di comprare quella marca o di vedere quella persona. Dovrebbe essere di tutti. Al tempo stesso, le altre persone, se hanno trovato persuasivi gli argomenti di Francesca, dovrebbero comportarsi di conseguenza.
–
In tutti e cinque questi esempî l’unica ragione per la quale tutte queste scelte non dovrebbero essere condivise è che non si reputa davvero amico la persona con la quale ci si proporrebbe di condividere quella cosa. Se nessuna delle tre le condizioni prima enunciate (disonestà, stupidità, cattiveria) si verifica, non esiste ragione per non condividere anche queste scelte. Se esiste una di queste condizioni, come si può chiamare davvero amica quella persona?
OBIEZIONI E RISPOSTE
– Ciascuno conosce meglio le proprie esigenze rispetto a chiunque altro!
Questo è vero, e infatti è sensato che il parere della persona che in prima persona dovrà trasferirsi in Australia (ad esempio) sarà il primo da tenere in considerazione, ma il fatto che anche altre persone partecipino alla valutazione di questi dati può essere solamente un vantaggio.
– Ma per fare questa operazione ci vuole moltissimo tempo!
Dipende. Sicuramente andare in profondità su cose banalissime è una perdita di tempo, e non vale il vantaggio di fare la scelta migliore (ho preso il treno alle 15.23 anziché alle 16.23, e quello delle 16,23 ci metteva 10 minuti meno), ma su decisioni estremamente importanti non c’è – virtualmente – alcun limite di tempo che valga la perdita di precisione della risposta. Se bisogna prendere decisioni che incidono significativamente sul benessere di un figlio, anche il suo stesso concepimento, non c’è – sempre virtualmente – un tempo che non vale la pena perdere per garantirgli (e garantire a noi) più benessere. Fra questi due estremi ci sono moltissime vie di mezzo, e il fatto che su alcune decisioni non valga la pena perdere tempo, non vuol dire che su alcune altre non sia importantissimo.
– E se alla fine non si è d’accordo?
Innanzitutto, se si parte da premesse simili (quelle sopra, evitare la sofferenza di tutti, etc.), e si è intelligenti – nel senso che si riconosce l’intelligenza altrui quando, e sui temi in cui, sia superiore alla propria – con tempo infinito si raggiunge inevitabilmente la stessa conclusione. Naturalmente non abbiamo tempo infinito e ci saranno temi sui quali, come detto sopra, si pensa che il beneficio di chiarire una questione non valga il tempo speso a chiarirla. Ma questo non esclude che si condividano gli altri temi, e si condividano (nel modo più ragionevole e condiviso) anche le conseguenze di queste divergenze condivise.
– E allora perché non lo facciamo tutti?
Non lo facciamo tutti perché sono poche le persone di cui siamo certi che non siano disonesti, stupidi o cattivi (come definite sopra). Venuto meno uno di questi requisiti, la condivisione è inapplicabile. *aggiunta del 6/10: Molti di noi, che hanno un buon rapporto con il/la proprio/propria compagna già usano questo metodo con lei/lui: la ragione per la quale questo trattamento non si estende alle altre persone di cui ci si fida, gli amici, non c’è. In realtà il motivo per cui adottiamo il criterio “ognuno per sé” è che non ci fidiamo al 100% degli altri, perché se avessimo la garanzia che gli altri tengono al nostro benessere quanto ci teniamo noi, affidare loro le decisioni non avrebbe alcun costo, e bisogna sempre ricordarsi che qui stiamo cercando un sistema più efficace di “ognuno per sé” non un sistema infallibile.*
– E se una persona è meno capace?
La società in cui viviamo premia – o dichiara di premiare – la meritocrazia perché avere ponti che non cadono (architetti migliori) e pizze più buone (pizzaioli migliori) conviene a tutti, anche ai meno bravi. Ma non c’è ragione per punire chi non è capace, sempre che questo premio/punizione non dia incentivi o disincentivi. È possibile che alcune persone abbiano più incarichi di altri? Certo. Se a una persona scoccia meno degli altri fare la spesa, farà più volte la spesa. Se una persona sa aggiustare le macchine aggiusterà le macchine di tutti, in accordo con gli altri impegni e le altre incombenze. Sono tutte cose che si possono decidere con una discussione, per cercare di gestire meglio gli sforzi di tutti. Può essere anche che alcune persone puntino ad avere una vita più agiata di altri (vuoi una casa più grande? Vuoi fare vacanze più lunghe?), e conseguentemente facciano più sforzi su altri campi. Il concetto chiaro è che non c’è alcuna ragione che non sia disonestà, stupidità o cattiveria (come definite sopra) per prendere queste decisioni da soli e non assieme agli altri che si considerano amici.
– Ma quindi non è soltanto una cosa intragruppo, c’è anche una responsabilità verso gli altri, quelli che non fanno la condivisione?
Certo. Le scelte etiche che ciascuno fa sono basate su valutazioni e opinioni argomentate: quel negoziante non fa lo scontrino, io non ci vado; quella signora è in difficoltà, è giusto aiutarla. Quella persona si comporta male, non è giusto frequentarla. I casi della vita sono molto più complessi, ma alla base di ciascuna di queste decisioni c’è un ragionamento che non ha motivi di non essere condiviso. Perché dovrei escludere da una decisione una persona che considero onesta, intelligente e buona? Non potrebbe che aiutarmi a prendere la decisione migliore.
– E se una persona è più pigra o ha altri difetti?
Può essere che ci siano persone che non sono disposte ad avere lo stesso grado di impegno etico: andare a servire alla mensa dei poveri mi fa fatica, ad esempio. Rispetto a questo, ci si rapporta come tutte le altre cose: qualunque difetto che ha una persona deve essere valutato. Quella persona potrebbe migliorare? Sopperire a questo difetto, provvedendo per quella persona, disincentiverebbe la persona dall’impegnarsi? Ciascuna di queste domande deve essere analizzata, caso per caso, per prendere la decisione su come comportarsi, su quanta parte di pigrizia accettare. Ma questa è solo la mia opinione. Magari ne discutiamo e scopriamo che sbaglio e che bisogna avere un approccio diverso alla pigrizia. È una questione di metodo, non di contenuto. Qualunque di queste questioni è, necessariamente, inclusa nella premessa di metodo. Cioè che non c’è ragione per la quale questa decisione, come tutte le altre, non dovrebbe essere discussa e condivisa con le altre persone che consideriamo amiche.
– E se sbagliamo nel prendere le decisioni con questo metodo?
Sbagliamo e sbaglieremo sempre. Il metodo che adottiamo ora, cioè quello che abbiamo ereditato a caso dalla società nella quale siamo cresciuti, cioè “è meglio non condividere niente, se non i membri del proprio sangue” ha statisticamente più possibilità di essere sbagliato, proprio perché non è ragionato, ma è casuale. Ma sentire più pareri – e metterli nel processo decisionale – di persone alle quali si vuole bene, e che si considerano amiche, non può che essere positivo. Quindi, sì, certo che sbaglieremo, come sbaglieremmo con qualunque tipo di processo decisionale. Ma, condividendo le nostre decisioni con tutte le persone di cui ci fidiamo e che stimiamo, sbaglieremo di meno che prendendo tutte le decisioni di testa propria.
– Guarda che lo facciamo già!
Davvero pensi che in tutte le decisioni che prendi stai soppesando il tuo interesse e quello delle persone alle quali vuoi bene allo stesso modo? Consideri qualunque decisione che ti riguardi una decisione da gestire consensualmente con le persone alle quali vuoi bene? Se un tuo amico vuole andare in vacanza in Colombia, ti consulta prima di organizzare il viaggio? E se vuole cambiare lavoro? Domandati: se pensi a tutte le persone che sono tue amiche, ti senti coinvolto e responsabile per ogni cosa per la quale quelle persone si sentono coinvolte e responsabili? Lo fai già? Secondo me no. Se sì, ti voglio conoscere.
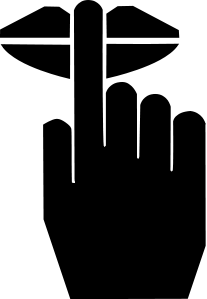 Questo, ovviamente, non rende la persona meno vittima: quale che sia la reazione di una vittima di un’ingiustizia, quella persona ha diritto – e noi abbiamo il dovere di darlo – al conforto che, giustamente, proviamo per le vittime. E, altrettanto ovviamente, non cancella le circostanze – come lo stupro – nelle quali la vittima non ha alcuno spazio d’azione. Alcune non hanno avuto la possibilità di chiudersi in bagno. Ma la totale privazione dello spazio d’azione non può essere determinata, ipso facto, dallo squilibrio di potere fra le due persone coinvolte.
Questo, ovviamente, non rende la persona meno vittima: quale che sia la reazione di una vittima di un’ingiustizia, quella persona ha diritto – e noi abbiamo il dovere di darlo – al conforto che, giustamente, proviamo per le vittime. E, altrettanto ovviamente, non cancella le circostanze – come lo stupro – nelle quali la vittima non ha alcuno spazio d’azione. Alcune non hanno avuto la possibilità di chiudersi in bagno. Ma la totale privazione dello spazio d’azione non può essere determinata, ipso facto, dallo squilibrio di potere fra le due persone coinvolte.